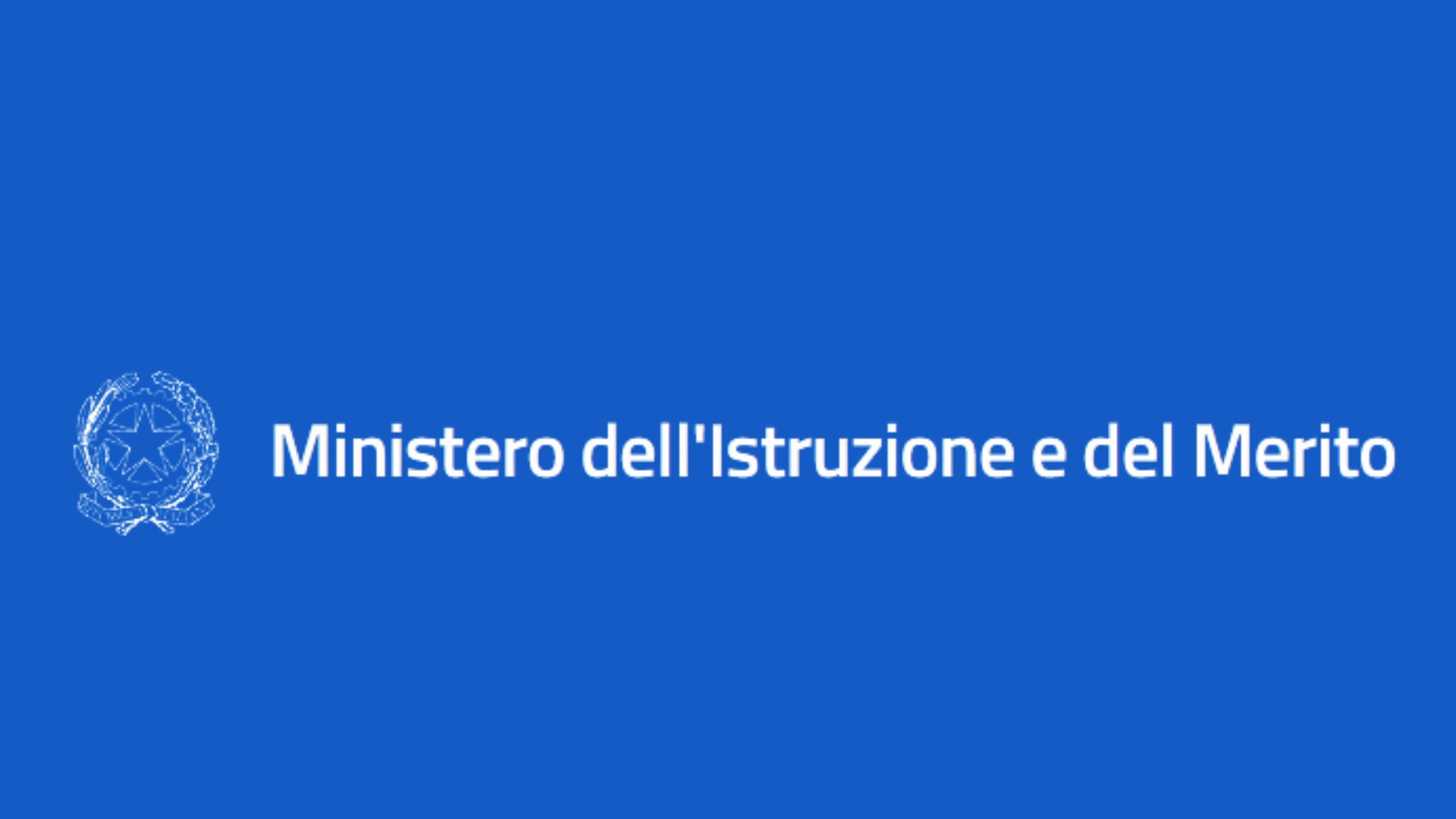Donne, giovani, Mezzogiorno (intervista a Roberta Bortone)
Michele Tiraboschi, che fu il principale allievo di Marco Biagi, il giuslavorista ucciso nel 2002 dalle BR, ha raccolto nel volume Venti anni di Legge Biagi (appena pubblicato da ADAPT University Press) le considerazioni di alcuni studiosi di Diritto del lavoro, sistemate in forma di intervista, che fanno il punto sugli effetti (o mancati effetti) che la Legge n. 276 del 2003, radicata nel Libro Bianco delineato da Biagi, ha prodotto in concreto.
Tra le interviste quella alla nostra Roberta Bortone (a pag. 114 ss. del volume) tende a fare il punto sui problemi relativi a donne, giovani, Mezzogiorno.
TIRABOSCHI – L’idea di una sussidiarietà applicata ai problemi del lavoro è stata, probabilmente, la pietra angolare su cui poggiava l’intero edificio della riforma Biagi. Trascorsi venti anni quale valutazione possiamo trarre, anche alla luce della esperienza applicativa, rispetto a questa idea?
BORTONE – Fin dagli ultimi anni del secolo scorso il centralismo delle competenze regolatorie e in generale delle politiche è stato oggetto di riflessioni critiche, tanto che con la c.d. riforma Bassanini era già stato introdotto il decentramento amministrativo come forma di anticipazione di un decentramento di competenze normative poi attuato con la riforma costituzionale. Ora, a distanza di un ventennio dalla quella riforma e dal Libro Bianco, e anche con l’esperienza collegata alla recente pandemia da Covid-19, il mio giudizio sulla spinta alla diversificazione territoriale è sostanzialmente negativo.
TIRABOSCHI – Per quali motivi?
BORTONE – Mi pare che siano aumentate in modo insopportabile le differenze tra le varie zone del nostro territorio e non solo per quello che concerne il mercato del lavoro. In quest’ambito, la mancanza di lavoro nelle regioni meridionali si è associata all’incapacità degli uffici preposti all’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro allo svolgimento della loro funzione di politica attiva del lavoro, con il conseguente fallimento – dal punto di vista delle politiche attive del lavoro – anche di tutti gli interventi di sicurezza sociale collegati alla ricerca di un lavoro (da ultimo il “reddito di cittadinanza”). Ma il mio giudizio negativo circa la spinta verso un ulteriore federalismo vale anche in altri ambiti e soprattutto per la sanità, dove la diversificazione territoriale è stata così marcata da rendere necessari interventi centralistici nella gestione della pandemia.
TIRABOSCHI – La legge Biagi sovrapponeva o confondeva i concetti di sussidiarietà e di federalismo?
BORTONE – In realtà, la parte del tutto carente della spinta al decentramento regolatorio è stata proprio quella della sussidiarietà, secondo la quale la definizione delle linee generali dovrebbe essere affidata al livello statale e i livelli regionali si dovrebbero muovere all’interno di quelle indicazioni, con l’intervento dello Stato in caso di mancato o inadeguato intervento regionale. Invece il livello nazionale di fatto ha finito per abdicare del tutto al proprio ruolo e non ha neppure definito regole chiare alle quali si sarebbero dovuti attenere i legislatori regionali.
TIRABOSCHI – Era appena stata approvata la riforma del titolo V della Costituzione…
BORTONE – Ho già detto delle pecche nell’applicazione del principio di sussidiarietà; aggiungo ora che nella gestione del mercato del lavoro la riforma costituzionale del 2001 si è dimostrata inadeguata anche dal punto di vista formale. Infatti, per quanto riguarda le politiche attive del lavoro si sovrappongono tre diversi tipi di competenze: la competenza concorrente Stato/Regione per la gestione del mercato del lavoro, quella esclusiva regionale per la formazione professionale e quella esclusiva statuale per la previdenza sociale e quindi per tutti i trattamenti connessi alla disoccupazione. A questo complesso intreccio tra i livelli di competenze si è aggiunto poi lo svuotamento di funzioni in capo alle Province, che di solito erano individuate come il punto centrale delle politiche attive del lavoro.
TIRABOSCHI – Con quali conseguenze?
BORTONE – Già questi riferimenti formali spiegano in parte come la riforma del 2001 abbia aggravato le differenze nella gestione del mercato del lavoro a seconda della cultura amministrativa presente nei territori (si pensi all’utilizzazione della formazione professionale e ai controlli sullo stato di disoccupazione e a come la gestione di questi due fenomeni cambi nelle diverse Regioni). In sostanza, il quadro delineato a partire dalla riforma costituzionale del 2001 ha di fatto allargato la forbice tra le Regioni che già prima riuscivano a tenere abbastanza sotto controllo la gestione del mercato del lavoro, e quelle dove alla mancanza di lavoro si associava una visione tutta burocratica del collocamento.
TIRABOSCHI – Eppure di federalismo si è tornato a parlare in tempi recenti…
BORTONE – E’ evidente, a questo punto, che ritengo estremamente pericolosa l’attuale direzione presa dalla politica verso un federalismo ancora più marcato, che si può trasformare in una definitiva frammentazione del nostro Paese. La c.d. autonomia differenziata voluta dalle Regioni del Nord e basata sulla spesa storica sarebbe la fine del Mezzogiorno. Anche se è vero che troppo spesso le Regioni meridionali non riescono a spendere i fondi loro assegnati (si pensi, ad esempio, proprio ai fondi destinati ai servizi per l’impiego), è altrettanto vero che con il riferimento alla spesa storica quelle stesse Regioni sarebbero condannate per sempre a una ristrettezza che finirebbe per renderne definitivo il declino.
 TIRABOSCHI – In che termini?
TIRABOSCHI – In che termini?
BORTONE – Faccio un esempio: se in un territorio per qualsiasi causa mancano asili-nido, quel certo territorio resterebbe condannato a non averne mai se i trasferimenti fossero collegati alla spesa sostenuta fino a quel momento. Non a caso le Regioni del Nord, in barba a ogni principio di solidarietà, premono verso questa forma di autonomia proprio per conservare la loro posizione di vantaggio, mentre invece quelle meridionali si battono per contrastarla.
TIRABOSCHI – L’obiettivo del contrasto al lavoro nero e alla economia informale è stato uno dei leitmotif della riforma Biagi. Anche qui, cosa possiamo dire a venti anni di distanza?
BORTONE – Qui si apre un tema che non è limitato alla materia lavoristica ma coinvolge la nostra cultura istituzionale.
La premessa del mio discorso è che dal punto di vista dei singoli il lavoro nero è e sarà sempre più conveniente di quello regolare, e ciò non solo per i datori di lavoro ma spesso anche per i lavoratori delle categorie a basso reddito: per molti di questi, la regolarizzazione comporta la perdita di numerosi benefici anche di tipo familiare (ad es. quelli collegati all’ISEE) senza che in cambio derivino vantaggi neppure in previsione dell’ammontare pensionistico. Di conseguenza, il sommerso si diffonde soprattutto laddove manca un vero contrasto di interessi tra datori e lavoratori e cioè dove i redditi sono bassi come nel Mezzogiorno con la conseguenza che i lavoratori stessi ci rimetterebbero dalla riemersione, e perciò le spinte alla regolarizzazione non saranno mai efficaci.
TIRABOSCHI – Quali possibili risposte, allora?
BORTONE – Per tutti i motivi che ho sopra richiamato in termini di sintesi ritengo che l’unica via efficace di contrasto al lavoro nero sarebbe l’intensificazione e il miglioramento dei controlli, ma purtroppo le risorse destinate a questo sono fin troppo scarse, così come accade per quanto riguarda i controlli in tutti i campi. Siamo un Paese con ottime leggi che non vengono rispettate proprio per la mancanza dei controlli e insieme dell’applicazione certa delle sanzioni, e ciò dalle norme in tema di sicurezza sul lavoro a quelle del Codice della strada e così via: si aumentano le sanzioni ma non si adeguano i meccanismi di controllo indispensabili per l’applicazione delle norme.
TIRABOSCHI – La legge Biagi si poneva in ogni caso l’obiettivo di innalzare i tassi di occupazione, molto bassi nel Mezzogiorno soprattutto per quanto riguarda i giovani e la componente femminile della popolazione. I dati sul mercato del lavoro ancora oggi sono impietosi al riguardo. Quale è la ragione di tutto ciò?
BORTONE – Qui la mia risposta è breve: l’occupazione di alcune categorie non si incrementa con particolari benefici se manca il lavoro in generale. L’assenza di una politica industriale ha fatto sì che lo sviluppo economico del Mezzogiorno sia stato lasciato alla spontaneità di un mercato privo di una visione d’insieme e ciò ha di fatto penalizzato il Sud, dove tra l’altro quella che viene simbolicamente definita come “assenza dello Stato” ha consentito la diffusione di strutture malavitose sempre più potenti che alterano le corrette dinamiche del mercato.
TIRABOSCHI – Vista dalla prospettiva di chi vive nel Mezzogiorno, è al fallimento delle riforme del mercato del lavoro che si può imputare il passaggio inevitabile dalla utopia della piena occupazione alla utopia del reddito universale di base? Oppure le spiegazioni sono più complesse e vanno ricercate nelle nuove tecnologie e nella trasformazione stessa del lavoro?
BORTONE – Torno a quanto ho appena detto rispondendo al punto precedente. Qualunque riforma del mercato del lavoro non produce né effetti positivi né effetti negativi se mancano interventi che tendano a creare occasioni di lavoro.
TIRABOSCHI – E il reddito di cittadinanza?
BORTONE – Il reddito di cittadinanza è stato ed è uno strumento necessario, ma solo per il contrasto alla povertà assoluta e non certo come strumento collegato alle politiche attive del lavoro, come invece era presupposto dall’impianto complessivo dell’istituto. Tra l’altro i dati sulla diffusione del reddito di cittadinanza hanno dimostrato che la maggior parte dei suoi percettori sono persone non in grado di lavorare e non certo fannulloni da divano. Insomma, presentato come intervento di sostegno del reddito collegato alle politiche attive del lavoro, si è dimostrato uno strumento di contrasto alla povertà.
TIRABOSCHI – L’anello di congiunzione tra contrasto alla povertà e inserimento nel mercato del lavoro era rappresentato dai c.d. navigator…
BORTONE – L’idea dei “navigator” poi, è stata davvero strana e non solo nel nome, giacché ha creato una figura nuova, con la previsione di utilizzare risorse umane da formare per poi inserirle in strutture che si sapeva già in partenza – per le ragioni alle quali ho già accennato a proposito dei servizi per l’impiego – non sarebbero state in grado di fornire gli strumenti necessari per la collocazione nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito. Insomma: una scommessa persa in partenza e – ironia della sorte – gli stessi navigator si sono trovati ad essere in cerca di occupazione alla fine della loro esperienza.
TIRABOSCHI – Uno degli strumenti suggeriti dalla legge Biagi per contrastare la sotto-occupazione è stato il contratto di inserimento al lavoro pensato, in particolare, per donne residenti in aree geografiche caratterizzate da ampi divari occupazionali tra popolazione maschile e femminile. La chiave era quella della flessibilità anche salariale (col sottoinquadramento retributivo per la fase di ingresso) pensata in termini di emersione. Una chiave sbagliata o era giusto sperimentare in questa area dove la situazione sembrava ferma da decenni e con tassi di occupazione femminile regolari da terzo o anche quarto mondo?
BORTONE – Per quello che riguarda le donne sono certa che ogni tentativo vada sempre sperimentato, compatibilmente – è ovvio – con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Ma per la questione di genere il discorso si fa spinoso e complicato, perché nel Mezzogiorno l’occupazione femminile – e non solo quella regolare – si scontra con molteplici ostacoli.
TIRABOSCHI – Quali?
BORTONE – Prima di tutto, laddove mancano in generale le occasioni di lavoro è abbastanza normale, soprattutto in contesti di cultura patriarcale, che siano gli uomini, i breadwinner, piuttosto che le donne, e ciò anche in considerazione dei redditi maggiori che di solito gli uomini sono in grado di produrre e che perciò rendono più facile la rinuncia al lavoro de parte delle donne. A questo si aggiungono le considerazioni già fatte in ordine alla mancata convenienza dell’emersione del lavoro femminile nei casi in cui questa emersione faccia perdere benefici collegati al reddito familiare. E qui desidero anche sottolineare con forza quanto sia pericolosa – per gli stessi motivi appena esposti – per l’occupazione femminile ogni applicazione del c.d. quoziente familiare. Non mi piace soffermarmi, invece, sulla tradizionale mancanza di servizi alla famiglia (cura dei bambini, degli anziani e delle persone non autosufficienti) nelle regioni meridionali, perché nel mondo al quale aspiro la conciliazione tra casa e lavoro sarebbe cosa che riguarda uomini e donne indistintamente, se esistesse una reale condivisione di ruoli nella famiglia: non a caso anche a livello europeo per le questioni di genere si tende ormai a parlare di “condivisione” e non più di “conciliazione”.
TIRABOSCHI – In realtà tutto il modello di organizzazione e disciplina del mercato del lavoro era incentrato su un certo regionalismo avviato peraltro già con la riforma Treu del collocamento e sul punto solo implementata e perfezionata con la legge Biagi. Mi riferisco in particolare al regime degli accreditamenti per i servizi al lavoro come anche alle discipline regionali su apprendistato e tirocini formativi. Un modello obbligato, alla luce del Titolo V della Costituzione. In tempi recenti si è invero cercato, con il Jobs Act e il tentativo di riforma costituzionale, di tornare a un modello centralista. Partita chiusa visto l’esito del referendum o è tempo di rilanciare un serio dibattito su come governare i diversi mercati locali del lavoro?
BORTONE – In questi anni credo che la realtà abbia confermato la capacità delle strutture private accreditate di svolgere quella funzione di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro che le strutture pubbliche non riescono a svolgere anche in considerazione di quanto ho detto rispondendo alla seconda domanda; e da questo punto di vista le strutture private accreditate sono entrate appieno nel sistema integrato di servizi per l’impiego. Quanto ad apprendistato e tirocini formativi, compresi quelli collegati all’alternanza scuola-lavoro, come si sa sono venuti all’attenzione dell’opinione pubblica per gli infortuni anche mortali capitati ad alcuni ragazzi. Qui, ancora una volta devo sottolineare lo scostamento tra la filosofia sottesa in astratto ai diversi strumenti e la loro applicazione pratica, perché troppo spesso più che con l’intento di formare i giovani, questi istituti vengono usati come modo di utilizzazione di lavoro a basso costo. E anche in questo caso a mio avviso l’unico rimedio dovrebbe essere rappresentato da un miglioramento di tutta la filiera dei controlli.
TIRABOSCHI – La legge Biagi nasceva anche dalla controversa e dibattuta esperienza del patto Milano lavoro del 2000 dove si registrò la prima grande spaccatura tra CISL e CGIL, la prima favorevole alla iniziativa e la seconda decisamente contraria. Non a caso la legge Biagi apriva ampi spazi non solo ai patti locali per l’occupazione ma anche alla contrattazione territoriale sui tutti i principali ambiti della riforma. Una strada pericolosa o da confermare in epoca di globalizzazione che depotenzia il ruolo anticoncorrenziale del contratto nazionale di lavoro rispetto all’impiego del fattore lavoro?
BORTONE – Negli ultimi tempi mi ritrovo spesso ad interrogarmi sul ruolo che i sindacati sono in grado di svolgere in questo mondo del lavoro così diverso da quello nel quale sono nati e sul quale hanno incardinato la loro stessa essenza. Credo che se finalmente si arrivasse ad approvare una legge sulla rappresentanza sindacale, i contratti collettivi nazionali potrebbero svolgere appieno la funzione di determinazione del salario minimo, rendendo inutile tutto il dibattito su una legge finalizzata ad introdurlo. Ma al di là di questa funzione, forse i sindacati definiti “maggiormente rappresentativi” dovrebbero mettere in discussione la loro struttura di rappresentanza.
TIRABOSCHI – In che termini?
BORTONE – Oggi all’interno di una stessa azienda anche di dimensioni medio-piccole, si trovano a lavorare per uno stesso prodotto lavoratrici e lavoratori dipendenti da aziende merceologicamente diverse, alle quali sono legati da differenti tipologie contrattuali: quale sindacato è in grado di rappresentare questa molteplicità di persone, che necessitano tutte di tutela ma che sono portatrici di interessi non sempre coincidenti tra loro? Di certo questa funzione di rappresentanza non può essere svolta in modo efficace dai sindacati per ramo di industria che conosciamo oggi, nati per la tutela di lavoratori e lavoratrici in un periodo storico in cui l’unico conflitto all’interno di una determinata azienda era tra l’interesse dell’impresa e la tutela dei lavoratori legati da un rapporto di subordinazione con quel determinato imprenditore. Certo non spetta a me prefigurare un nuovo volto delle organizzazioni sindacali, oggi forse troppo arroccate nel tentare di mantenere determinate condizioni di potere, ma sono certa che fino a quando non si risolva questo problema di fondo, la discussione sulla struttura della contrattazione collettiva e sull’assetto delle relazioni industriali non porti a risultati utili.