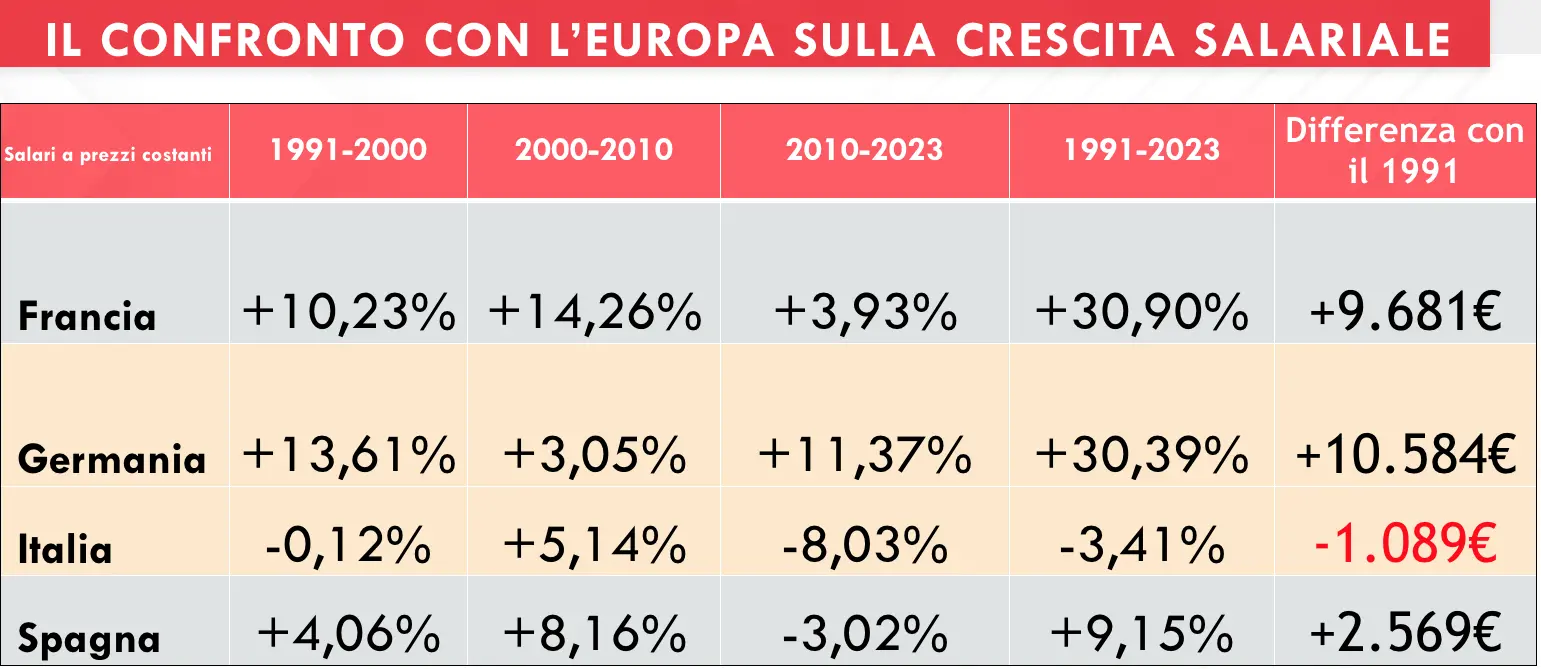La legge delega sul lavoro pubblico tra lotta ai “fannulloni” e riduzione della contrattazione collettiva
 Pubblicata da pochi giorni, la legge n. 15 del 4 marzo 2009, recante “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti” (in G.U. n. 53 del 5 marzo), vuole essere una tappa fondamentale dell’azione intrapresa dal ministro Brunetta – come è ampiamente noto, grazie ai mass media – verso una pubblica amministrazione più moderna ed efficiente, finalmente liberata dalla piaga dei “fannulloni”.
Pubblicata da pochi giorni, la legge n. 15 del 4 marzo 2009, recante “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti” (in G.U. n. 53 del 5 marzo), vuole essere una tappa fondamentale dell’azione intrapresa dal ministro Brunetta – come è ampiamente noto, grazie ai mass media – verso una pubblica amministrazione più moderna ed efficiente, finalmente liberata dalla piaga dei “fannulloni”.Al di là dello slogan che l’ha accompagnata, si tratta in realtà di una legge dal contenuto molto ampio, che disegna una profonda riforma, o per meglio dire una “controriforma”, della disciplina del lavoro pubblico. L’uso del termine “controriforma” – si badi – non vuole esprimere un giudizio negativo (non è certo questa la sede per valutare la bontà o meno di questo intervento legislativo, che del resto al momento è incompiuto, in attesa dei decreti delegati), ma si riferisce semplicemente ad un dato di fatto: questa legge compie scelte contrarie all’evoluzione che la disciplina ha avuto negli ultimi tre lustri circa, per quanto attiene al rapporto tra legge e contrattazione collettiva (come si dirà tra breve).
In estrema sintesi, si può dire che, sul versante della lotta ai “fannulloni”, la legge n. 15 contiene un numero nutrito di norme che mirano all’obiettivo di elevare la produttività del lavoro nelle PP.AA. Semplificando, si può dire che sembrano riconducibili a questa finalità almeno tre gruppi di norme, tra loro strettamente connessi.
Si tratta, in primo luogo, delle norme rivolte a sollecitare incisivamente i dirigenti pubblici ad esercitare il potere disciplinare che la legge riconosce loro (certo non da ora). In questo senso, la legge (si veda soprattutto l’art. 6) delega il Governo ad introdurre una serie di ipotesi di responsabilità per il dirigente che: ometta di “vigilare sulla effettiva produttività delle risorse umane assegnate e sull’efficienza della relativa struttura” (e in tal caso il dirigente perderà il trattamento economico accessorio); “non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti, nei casi in cui sarebbe stato dovuto” (ed anche in tal caso la conseguenza sarà la perdita del trattamento economico accessorio); non avvii il procedimento disciplinare entro i termini di decadenza previsti, ovvero renda “valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate” (qui viene delegata al governo l’individuazione di “sanzioni adeguate”).
In secondo luogo, con diretta incidenza sui dipendenti, intervengono le norme rivolte ad inasprire le conseguenze derivanti da comportamenti “disonesti”, ma anche da comportamenti per così dire contrari alla produttività ed all’efficienza. Così, per quanto attiene alle infrazioni disciplinari, la legge (art. 7) delega il governo, tra l’altro, a definire (per legge, quindi, non più per contratto collettivo) la tipologia delle infrazioni disciplinari che comportano la sanzione del licenziamento e ad introdurre una specifica ipotesi di reato per il dipendente che presenti certificati medici falsi, nel qual caso anche il medico – se dipendente pubblico – che abbia concorso alla falsificazione (oppure abbia anche solo violato i “canoni di diligenza professionale nell’accertamento della patologia”) è suscettibile di licenziamento in tronco. Per quanto attiene ai comportamenti improduttivi, la legge intenderebbe punire – se ben si comprende – non solo quelli evidenti e riferibili ad una singola persona, ma anche quelli “diffusi” e quindi più difficili da attribuire a singoli dipendenti. Ed infatti, da un lato si delega il governo a prevedere il licenziamento del personale che abbia arrecato “grave danno al normale funzionamento degli uffici di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale”, e dall’altro si prevede una penalizzazione (consistente nel divieto “di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere”) per tutti i dipendenti di uffici o strutture “individuati per grave inefficienza e improduttività”.
Infine, il terzo gruppo di norme è relativo ai controlli. Su questo versante, oltre a nuove funzioni e compiti per la Corte dei conti, spicca (art. 4) in primo luogo l’istituzione di un nuovo organismo centrale (in seno all’Aran) che avrà fondamentalmente il “compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione” delle performance delle PP.AA. secondo parametri oggettivi utilizzati anche a livello internazionale. In secondo luogo, spicca il forte impulso alla “trasparenza” dell’azione amministrativa: si prevede, infatti, che ogni amministrazione debba fissare annualmente i propri obiettivi, valutabili secondo parametri omogenei per tutte le PP.AA., e darne conto nell’ambito di confronti pubblici (anch’essi a cadenza annuale) che dovrebbero avere ampia partecipazione da parte soprattutto della società civile (associazioni di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di informazione, ecc.). Come corollario di questa maggiore trasparenza la legge prevede anche una nuova azione “popolare”: chiunque infatti potrà agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, quando dalla violazione degli standard qualitativi e degli obblighi previsti dalle Carte dei servizi, oppure dal mancato esercizio dei loro poteri di vigilanza, controllo e sanzione, ovvero dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali, derivi la “lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori”. Questa azione può sfociare, in ultima istanza, nell’ordine del giudice amministrativo alla P.A. di porre in essere le misure idonee a porre rimedio alla situazione (per quanto attiene al risarcimento del danno resta invece ferma la disciplina vigente).
Sembra evidente che la lotta contro il lassismo e la bassa produttività viene combattuta soprattutto in chiave repressiva e sanzionatoria: per così dire, si vuole usare molto di più il bastone della carota. Gli strumenti di stimolo all’eccellenza e di premio del merito sono infatti pochi e delineati con molta approssimazione: in buona sostanza ci si limita ad affermare che “percentuali minime di risorse” debbono “essere destinate al merito e alla produttività” (per i dirigenti “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la componente della retribuzione legata al risultato” deve essere non inferiore al 30 per cento”).
Solo il tempo, comunque, dirà se queste nuove norme saranno in grado effettivamente di raggiungere l’obiettivo di aumentare la produttività del lavoro pubblico e contrastare i fenomeni tanto deprecati di scarsa attitudine alla fatica nelle PP.AA.
Per ora, quello che è certo è che la legge n. 15 interviene incisivamente – come si è già accennato – nel senso di modificare i rapporti tra la legge e la contrattazione collettiva, nel senso di attribuire nuovamente alla prima spazi che, a partire dagli anni ’90 si era ritenuto che fosse meglio attribuire alla seconda. In questo senso si tratta di un ritorno al passato.
È emblematico l’art. 1 della legge n. 15, che interviene direttamente a capovolgere una norma cardine del decreto 165/2001. L’art. 2, comma 2 del d.lgs. 165/2001 stabiliva che eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto volte ad introdurre discipline dei rapporti di lavoro limitate ai dipendenti delle PP.AA. o a categorie di esse, potevano essere derogate da successivi accordi collettivi e per la parte derogata non erano più applicabili. Si trattava di una norma, in altri termini, che affidava alla contrattazione collettiva un ruolo importante, quello di impedire al parlamento e al governo, insomma alla politica, di intervenire con provvedimenti clientelari che, in un passato non lontano avevano portato alla creazione della “giungla” del pubblico impiego, dove ogni categoria di dipendenti che fosse in grado di esercitare pressione otteneva una legge ad hoc che accontentava le sue richieste (efficacemente si parlò di “leggine”).
Questa norma aveva acceso la discussione tra gli esperti, soprattutto perché, ad una lettura superficiale, faceva pensare ad un rovesciamento delle fonti del diritto: il contratto collettivo (che nel nostro ordinamento è espressione dell’autonomia privata) veniva infatti abilitato a derogare a fonti ad esso superiori, tra le quali in particolare la legge. In realtà, la legge non perdeva certo il suo ruolo nella gerarchia delle fonti: infatti, come quella stessa norma affermava, la legge che eventualmente intervenisse “ad introdurre discipline dei rapporti di lavoro limitate ai dipendenti delle PP.AA. o a categorie di esse” poteva impedire al contratto collettivo di intervenire, ma doveva dirlo espressamente, e quindi il potere politico doveva venire allo scoperto e assumersi le sue responsabilità.
Ebbene, la legge n. 15 capovolge l’art. 2, comma 2: d’ora in avanti, infatti, il contratto potrà derogare e rendere inapplicabili trattamenti particolaristici (le “leggine”) soltanto qualora sia la stessa legge che introduce il trattamento a consentirlo. A prima vista sembra, francamente, non solo un ritorno al passato ma anche un nonsense alla luce della logica.
Alla contrattazione collettiva viene quindi sottratto il compito, che le era stato affidato dalle riforme del lavoro pubblico degli anni ’90, di arginare derive clientelari della disciplina pubblicistica. Del resto, la disciplina pubblicistica, come si è già accennato, nel disegno della legge n. 15 riguadagna terreno (oltre al già citato art. 1 si veda in particolare l’art. 3). Ed infatti il Governo è delegato, tra l’altro, a precisare gli ambiti riservati alla legge e quelli riservati alla contrattazione collettiva (alla quale viene comunque riservata la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro), nonché ad individuare criteri per la fissazione di vincoli alla contrattazione collettiva al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio. Inoltre, si prevede il divieto per la contrattazione di istituire collegi arbitrali di disciplina con la contestuale soppressione di quelli esistenti.
Si può dire, in conclusione, che, in un provvedimento che è stato etichettato come legge “anti-fannulloni”, sembra trasparire una certa insofferenza o insoddisfazione per quanto è stato realizzato dalla contrattazione collettiva. Questa insoddisfazione vuol dire, a ben vedere, insoddisfazione verso il soggetto che si intendeva valorizzare e responsabilizzare con l’ampliamento degli spazi della contrattazione collettiva, ossia il sindacato (molto significative di una insoddisfazione verso l’azione del sindacato, del resto, sono le norme rivolte al “rafforzamento dell’indipendenza dell’ARAN dalle organizzazioni sindacali”). Certamente questa insoddisfazione verso la contrattazione collettiva ed il sindacato, può essere condivisa (almeno in parte), così come può essere condivisa in una certa misura l’insoddisfazione verso l’operato dei dirigenti pubblici, spesso poco attenti a controllare e sanzionare i fannulloni.
Ma sarebbe scorretto (oltreché controproducente) dimenticare un dato imprescindibile: i risultati della contrattazione collettiva e l’operato del sindacato, così come l’operato della dirigenza pubblica, sono fortemente condizionati da come, a monte, il potere politico interpreta il proprio ruolo di vero “padrone” dell’amministrazione e, quindi, da quanto il potere politico rispetta da un lato il principio di separazione tra politica e dirigenza e dall’altro la distinzione di ruoli con il sindacato.
Dott. Antonio Aurilio
(Docente a contratto di diritto del lavoro nell’Università di Roma “La Sapienza”)